Architettura
La proporzione aurea si ritrova nelle costruzioni dell'uomo fin dai tempi degli antichi egizi. Nella piramide di Cheope il rapporto tra l'apotema ('altezza di una faccia) e metà della base corrisponde al numero d'oro anche se è difficile accertare che questa scelta sia stata voluta.
Anche gli archi di trionfo della Roma classica si rifanno alla proporzione aurea ma anche altre civilta', molto lontane dalla cultura classica, sembrano apprezzare la proporzione aurea: non lontano dal lago Titicaca, vicino all'attuale capitale della Bolivia, La Paz, troviamo la Porta del Sole, monumento di una cultura preincaica risalente al 1500 a.C., interamente proporzionato in base a phi.
L'esempio che da sempre e' considerato il piu' rappresentativo dell' uso della proporzione aurea è il Partenone: non per nulla il nome moderno della sezione aurea, phi, e' l'iniziale del nome del suo costruttore, Fidia.
Sicuramente non possiamo essere sicuri di un uso reale e consapevole da parte dei costruttori della sezione aurea; il desiderio di trovare questa relazione in tutti i campi della pittura, della scultura, dell'architettura potrebbe aver tratto in inganno gli scienziati: prendendo le misure adeguate di qualsiasi monumento possiamo sempre scovare il nostro numero anche se l-architetto non vi aveva minimamente pensato.
Indubbiamente possiamo dimostrare che la divina proporzione nel Medioevo venisse utilizzata in modo consapevole dato che è spesso documentata dagli stessi autori. Il pentagono regolare, il pentagono stellato o il rettangolo aureo appaiono come schemi di base per sculture o interi edifici come si puo vedere nella facciata gotica dell'Universita di Salamanca in Spagna.
Luca Pacioli e molti altri artisti del Rinascimento mettono «l'uomo e le sue meravigliose proporzioni segnate dal dito dell'Altissimo» al centro di tutte le arti affermando che gli «antichi hanno conformato tutte le loro opere, soprattutto i sacri templi, alle proporzioni del corpo umano, dal momento che in quelle trovano le due figure principali senza le quali non e possibile fare nulla, ovvero il quadrato e il cerchio».
Come la pittura anche l'architettura fu influenzata dal numero d'oro: Le Corbusier sostenne che il sistema metrico decimale aveva spersonalizzato gli strumenti di misurazione perdendo il contatto con la scala umana. Per recuperarla ideò una sua propria scala basata sulla proporzione aurea adattata ai tempi moderni; come risposta all'uomo Vitruviano ideò il Modulor: «il metro, il decimetro e il centimetro non sono a scala umana, il modulor si». Negli anni della seconda guerra mondiale scrisse un libro su questo argomento, pubblicato nel 1950, in cui parlava di questa sua idea e progettava una serie di oggetti di uso comune basati sulla proporzione aurea e sulle misure standard di un uomo anglosassone (1,82 cm). Successivamente nel 1955, nel Modulor2, adattò queste misure a quelle medie dell'uomo latino. In pratica il sistema del Modulor riprendeva l'ideale classico cercando di mettere in relazione la proporzione degli edifici e quelle degli uomini.
Nella diapositiva la statua del modulor e la facciata del palazzo delle Nazioni Unite a New York con tre rettangoli aurei al cui progetto partecipo Le Corbusier insieme al suo discepolo Niemeyer (architetto che realizzà Brasilia).
Altri architetti moderni si fecero ispirare dalla natura: Wright disegno la rampa del museo di arte moderna di New York Guggenheim imitando la spirale del Nautilus mentre il polacco Zvi Hecker si ispiro alla struttura del girasole per costruire le scuole Heinz-Galinski con le aule che sono illuminate dai raggi solari in sequenza durante l'arco della giornata.
Architettura
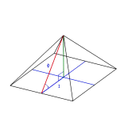 Piramide di Cheope, Egitto
Piramide di Cheope, Egitto Porta del Sole, Bolivia
Porta del Sole, Bolivia Partenone, Grecia
Partenone, Grecia Università di Salamanca, Spagna
Università di Salamanca, Spagna Modulor, Le Courbusier
Modulor, Le Courbusier Palazzo delle Nazioni Uniti, New York
Palazzo delle Nazioni Uniti, New York  Progetto del palazzo a ricordo dell rivoluzione russa del 1917
Progetto del palazzo a ricordo dell rivoluzione russa del 1917 Scuola ebraica Heinz-Galinski, Zvi Hecker, Berlino
Scuola ebraica Heinz-Galinski, Zvi Hecker, Berlino Scale del Guggenheim, New York
Scale del Guggenheim, New York